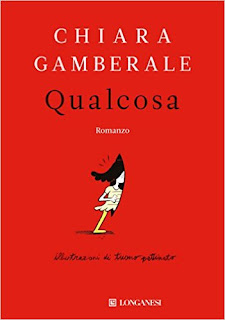Qualcosa è la sua nuova avventura, anche dal punto di vista formale e stilistico. Come è nata?
Io cambio sempre. Quello che non cambia sono le mie ossessioni. Tutti i libri di un autore si parlano. Ed è quello che io cerco in uno scrittore. Non mi fido di chi prima scrive un giallo, poi un romanzo d’amore e poi prova con l’auto-fiction: ma qual è la sua vera urgenza? Senza dubbio la mia narrativa ruota attorno ad alcune paure e ogni mio libro è il tentativo di affrontarle da un punto di vista diverso per ricavarne nuove verità.
Ha scelto una forma inedita contaminata con le illustrazioni…
Fin dall’adolescenza coltivavo il desiderio di scrivere qualcosa alla Calvino, un universo completamente immaginato da me, in cui potessi inserire le mie domande. Dopo di che mi sono detta che sarebbe stato bello dialogare con un illustratore. Mi ero innamorata di Tuono Pettinato, della sua vena poetica, grazie a una raccolta in cui c’era anche Zerocalcare. Poi l’ho ritrovato su Internazionale e leggendo Nevermind sulla vita di Kurt Cobain, mi ha davvero strappato il cuore. Così l’ho chiamato e lui si è messo a disposizione. È un vero artista.
Come si è articolata la vostra collaborazione?
Ho iniziato a scrivere pensando alle illustrazioni. Gli ho consegnato il testo e lui l’ha corredato, ma non si è limitato a seguire le mie indicazioni. Essendo anche un autore, ha risposto ad alcune sollecitazioni e ad altre no, per cui è iniziato un dialogo. La scrittura a sua volta si è sintonizzata sulle sue proposte. Ne è venuto fuori qualcosa che, nonostante sia ambientato in un regno che non c’è, affronta problemi umani troppo umani.
In Qualcosa si percepisce la volontà di andare all’essenza, al cuore di quelli che sono i personaggi dei suoi romanzi, a partire dai nomi. Forse l’operazione più difficile per uno scrittore: avere la profondità di un classico, un senso di universalità.
È vero ed è stato faticosissimo perché io ho la testa piena di parole e di pensieri. Mi sveglio la mattina con un’orchestra stonata nella testa. Ho lavorato molto per raggiungere una scrittura che avesse a che fare col classico, cioè con qualcosa in grado di restare. Per questo pensavo a Calvino, a Saint-Exupéry. Non a caso nell’edizione Feltrinelli ho curato la prefazione. E poi Pinocchio: lo adoro. In un corso molto interessante di psicanalisi e letteratura con Stefano Ferrari, si sottolineava quanto lo stile sia terapeutico per l’umore. Per me che sono un tipo ansioso, racchiudere tutta la mia urgenza in uno stile che abbia poche parole e pochi nomi è stata una grandissima sfida dal punto di vista letterario. La protagonista si chiama Qualcosa di Troppo, suo padre il re, Qualcosa di Importante. Solo col loro nome ti ho già detto chi sono.
Uno stile molto diverso da quello di Adesso, il suo precedente romanzo…
Sì, venivo da un testo nevrotico come Adesso, un romanzo sul momento, su cosa diventiamo in un attimo fatale e la scrittura era a servizio di quella brachicardia. E invece Qualcosa è un romanzo su che cosa siamo oggi e sempre’ e la scrittura doveva mettersi a servizio di questo respiro.
In Qualcosa affronta anche il tema della necessità di disconnettersi da una società dove il maggior passatempo dei ragazzi è tuffarsi in Smorfialibro, alias Facebook. Quanto è importante oggi riappropriarsi di sé a prescindere dal sé virtuale?
“Rispondo con questo (e ci mostra il suo cellulare modello basic). Perfino io che non possiedo uno smartphone e cerco di difendermi da questi strumenti, non sono stata indenne dal caderci. Può succedere in tanti modi, persino senza accorgersene. Essendo una persona compulsiva mi sono tenuta a distanza dai social network. Eppure, come raccontavo qualche mese fa in un pezzo per La Stampa ci sono cascata anch’io. Credo in generale sia un problema enorme”.
E questo disagio emerge nel libro.
Sì, in questo romanzo, che è sui nostri sempiterni impedimenti, l’amore e la morte, c’è qualcosa che, a proposito di pieno e di vuoto, ha a che fare proprio con l’oggi, cioè i social network. Questo è un mondo in cui paradossalmente la società sembra venirci incontro rispetto al vuoto. In realtà ci sta dando solo dei falsi amici, dei tranelli. Quante persone dopo la fine di una relazione studiano il profilo Facebook dell’ex partner? Come se si potesse davvero capire qualcosa di una persona da lì. E il rischio è quello che arrivi a convincerti che la tua stessa identità sia quella del tuo profilo virtuale. E cosa accade nei due momenti cruciali della vita, quando muore qualcuno di caro o ci si innamora, nei momenti dunque dei grandi dolori e delle grandi felicità? Se non ti conosci, sono esperienze che ti frantumano e non possono nemmeno arricchirti. Spero di aver dato un allarme con questo romanzo. Senza comunque dimenticare l’ironia.
Una delle soluzioni proposte dal libro può essere quella del silenzio come suggerisce il Cavalier Niente. Oppure, come scriveva in quell’articolo che menzionava, “regalatevi Proust e vi toglierete le ansie del web”. A proposito di tempo perduto e ritrovato…
Esatto. Ero caduta nel vortice del controllare ossessivamente cosa la gente scrivesse di me sul web. Sentivo che c’era un pericolo e mi sono curata con Proust, aiutata dal fatto che la mia vita è divisa in due: quella in cui scrivo in isole fuori dal mondo e anche dalla gente, in cui la connessione funziona malissimo; e quello in cui sono in Italia con le mie relazioni e le mie presentazioni. Il mio rischio è quello di essere sommersa dagli altri, come in un movimento di sistole e diastole, niente o troppo. Ho approfittato questa estate, quando sono stata nell’isola di Milos per scrivere Qualcosa, per iniziare la mia terapia d’urto: leggere i sette volumi della Recherche.
Cosa la spaventa in particolare?
Da piccola passavo ore intere del pomeriggio dal portiere. I miei lavoravano entrambi. E in quei pomeriggi mi annoiavo, avevo paura, mi concentravo. Provavo insomma sentimenti, anche negativi, ma di cui tutti abbiamo bisogno. Ed è nella guardiola di quel portiere che ho scritto il mio primo romanzo. Avevo 7 anni e mezzo: Chiara e Riky e Chiara e Riky crescono, influenzata palesemente da Piccole Donne. A volte mi chiedo: se fossi nata oggi, sarei riuscita a concentrarmi così tanto da iniziare a scrivere? Oppure sarei stata distratta da tutto questo ‘troppo’ che ci circonda? Ecco perché ho scritto questo romanzo in due direzioni, cioè guardando dentro l’essere umano, che è fatto così, e poi all’esterno, con questa società che non lo aiuta. Apparentemente sembra farlo, ma in realtà lo mette più a rischio.
Un messaggio trasversale, ma che può essere ancora più incisivo per i ragazzi. E non è un caso che il ricavato di questo libro andrà a Casa Oz, l’associazione che si occupa dei bambini che incontrano la malattia e delle loro famiglie.
Era la cosa giusta. Da un anno, quando vengo chiamata dalle scuole, anziché presentare il mio libro, vado a fare educazione sentimentale. Penso che noi scrittori abbiamo una missione, politica e culturale. Quindi faccio spegnere loro il cellulare per quelle tre ore, pretendo che abbiano letto il libro – anche tramite fotocopie, non è un problema – ma è necessario, altrimenti risulta una perdita di tempo. E poi giochiamo con i temi del libro. Con Adesso abbiamo fatto un laboratorio sulle paure e sui desideri. Son emersi gli spunti più disparati. Con Qualcosa mi potrò sbizzarrire con un nuovo laboratorio sul vuoto e su come lo si può riempire.
I suoi libri hanno sempre un risvolto pragmatico. Pensiamo a Per dieci minuti, al curriculum sentimentale in Adesso, alle parole illustrate di Qualcosa che sono un autentico monito…
Sono la mia prima paziente. Mi ha fatto sorridere sentire un prete dirmi che in confessione invitava i suoi fedeli a recitare tre Ave Maria e a leggere Per dieci minuti. Ormai è entrato nelle terapie psicanalitiche. È un libro che ha superato i confini della letteratura ed è entrato nella vita vera.
Perché secondo lei?
Perché i lettori hanno sentito che c’era un’esperienza vera dentro. Io l’avevo provato per tutti. Non avevo deciso di scriverne un libro, ma il decimo giorno di quell’esperimento mi sono detta: ‘I lettori hanno condiviso con me tanti loro guai; per una volta ecco una soluzione’.




![Romano De Marco [INCONTRO/17]](https://redkedi.it/wp-content/uploads/2017/03/images_2017_Eventi_Immagini_Varie_Red_kedi_con_Romano_De_Marco-960x675.jpg)